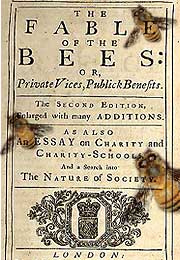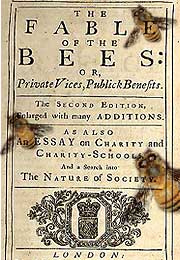
Mi ha colpito uno spunto che ho trovato tempo addietro in uno scritto del compianto maestro, nonché amico, Cesare Mozzarelli, che a sua volta si rifaceva a un’idea colta nella Favola delle api di Bernard de Mandeville, quella dei “vizi privati e pubbliche virtù”, per intenderci.
Rifletto quasi ininterrottamente su quello che mi sembra il “problema dei problemi” del mondo di oggi: che definizione dare e quindi quale giudizio formulare e, infine, che atteggiamento tenere nei confronti della modernità? Va accettata in pieno, in una logica di ineluttabilità superiorità valoriale di “ciò che viene dopo”? È puro male? È “la” Rivoluzione? Oppure va sceverato al suo interno il loglio dal grano? E riportata alle sue basi umanistiche, ora che è diventata per più di un aspetto “troppo umana” e non di rado anti-umana?
Ogni spunto che mi aiuti in questo è per me prezioso.
Per cui apprezzo il pensiero di Mozzarelli — che ovviamente riassumo e “riduco” —, secondo il quale il problema, e in certa misura il dramma, dell’uomo moderno starebbe nell’“abnorme” e crescente dilatazione della sfera dei diritti individuali che la modernità ha portato con sé. Ovviamente Mozzarelli, storico dell’età detta “moderna” per la predominanza di tale realtà — almeno — in seno alla civiltà occidentale, ha l’occhio più attento ai fenomeni del periodo in cui questa crescita è agli inizi, forse anche alla maturità, ma non certo al parossismo attuale.
In un orizzonte, come quello del pensiero moderno, in cui — in tesi — si muovono non più “corpi”, come nel Medioevo, ma individui, in cui la tradizione è azzerata, il limite puramente naturale (il freddo degli inverni o il buio della notte, per esempio) (gli elementi pre-razionali) sbiadisce e non esiste per definizione alcun elemento normativo di origine religiosa (l’elemento meta-razionale) che influisca sulla sfera morale, quest’ultima è presidiata dalla mera razionalità cartesiana ed è aperta a tutte le derive che l’esperienza storica ci ha ormai fatto conoscere riguardo a questa forma di razionalità.
Per garantire dunque quella che gli autori sei- e settecenteschi chiamano “la felicità” — naturalmente su questa terra —, per rendere possibile razionalmente questo ampliamento dei diritti — il termine ultimo, cui ci stiamo pericolosamente avvicinando, è la coincidenza fra diritto e desiderio —, per evitare che il moltiplicarsi degli atti a tale libertà conseguenti non porti a frizioni, a cozzi, a conflitti, la sfera pubblica deve sviluppare proporzionalmente le sue leve, i suoi meccanismi di controllo, di prevenzione e di eliminazione dei conflitti, di ripristino dei diritti quando essi siano violati.
Da qui, soprattutto nell’Europa della riflessione post-westfaliana, nasce la crescente “trofìa” e poi “ipertrofìa” dell’apparato pubblico, degli organi di polizia, degli eserciti, dei magistrati, dei catasti, delle anagrafi, e via dicendo.
Mi sembra una intuizione eccellente. La prima modernità, quella pre-industriale ha risolto in termini efficienti questa antinomia fra ampliamento dei diritti e dimensioni e complessità degli apparati sociali: in fin dei conti si trattava di diritti di pochi… Peggio inizia ad andare con le società liberali dell’Ottocento, ma il tutto ancora “tiene”…
Il salto si opera all’inizio del Novecento con la nascita della civiltà di massa, quando i conflitti sociali si fanno sempre più numerosi…
La traiettoria dello Stato moderno sempre più esteso, sempre più articolato nella sua amministrazione, sempre più popolato, se non affollato, di commis, funzionari, impiegati, tecnici contabili, dipendenti, sempre più vorace fiscalmente, sempre più ferreo nel dominio su quelli che non si chiamano più sudditi ma cittadini, descrive bene questo processo sincronico di crescita.
E si può dire che fino agli anni 1950-60, fino a che è durata la modernità “dura”, l’organizzazione sociale razional-burocratica-industriale alla Max Weber o alla Henry Ford, la condizione è stata ancora di equilibrio: diritti sempre più grandi, apparati sempre più estesi...
Chi ha vissuto in una grande città europea o italiana in quest’epoca — come il sottoscritto — ricorda ancora l’ordine che vi regnava, la pulizia che almeno nella maggior parte dei quartieri era un dato acquisito, i mezzi di trasporto in condizioni civili, una circolazione certo rarefatta rispetto a oggi ma scorrevole… Non che non vi fossero ubriachezza, prostituzione, furti, delitti, oscenità: ma il tutto riusciva ad essere controllato o, almeno, represso dalle strutture preposte.
Il punto di non ritorno è stato varcato credo con gli anni Sessanta e Settanta. Con l’esplosione del desiderio illimitato che si apre emblematicamente nel 1968 e il mutamento culturale, ossia di senso comune della gente, che ne deriva, con le migrazioni e con il nomadismo periodico scientemente coltivato, le cose cambiano. Le strade cittadine — ma anche le arterie commerciali — non riescono più a contenere il cresciuto numero di veicoli, la nettezza urbana non riesce più a tenere pulite le città, la criminalità cresce e si fa di giorno in giorno più audace, i treni sono sempre più sudici, la violenza politica scende nelle strade…
Oggi, quando la coppia desideri-diritti è diventata la politica, l’unica politica, di ampi schieramenti ideologici e partitici, siamo vicini al collasso.
Casi clamorosi come le immondizie in Campania, l’infiltrazione silenziosa di migliaia di comunità esotiche, cinesi, nordafricane, filippine, sudamericane, il traffico fuori controllo, la pornografia ormai ambientale, la pedofilia scatenata, le periferie a rischio di sedizione, la pratica depenalizzazione di centinaia di delitti per impossibilità di reprimerli, il dilagare della prostituzione a cielo aperto, l’impossibilità di aver dalla propria l’autorità pubblica impersonata da un vigile o da un poliziotto, in tanti, troppi frangenti, ne sono le spie. Per tenere sotto controllo — ovvero solo a un livello di non conflittualità o di conflittualità a basso livello agglomerati enormi, così privi di identità, così atomizzati occorrerebbero apparati davvero da Stato totalitario, da polizia cinese.
Il quesito è: può la convivenza umana sopportare la dilatazione di questa coppia diritti-apparati all’infinito? Fino a quando? Vi è un limite fisiologico ai diritti? Come intervenire, se così fosse? Solo riducendo i diritti e reprimendo? O rieducando?
Certo il primo passo è prendere coscienza che la modernità presenta delle aporie. Che non è una rivelazione divina alternativa a quella cristiana: semmai il suo rovescio parodistico.
Ci si trova oggi di fronte al paradosso che per avere più libertà poi ci si trova oggettivamente limitati nel suo godimento. La modernità si rivolta contro sé stessa. L’agibilità dei diritti conquistati non è più piena. Lo Stato è impotente a garantire una tale vita alla società, una vita così “eccentrica” perché priva di “centro”, come teorizzava Hans Sedlmayr.
Lo Stato, pur drenando sempre più risorse per far funzionare il suo pletorico apparato, abbandona la società a sé stessa e il substrato morale e i residui di tradizione sopravviventi, che fanno da collante provvisorio, sono sempre più erosi e insufficienti. Né davanti alle sue carenze allenta la morsa fiscale e lascia libera la società di auto-organizzarsi e di provvedere a proprie spese ai servizi e alle sue necessità…
Si vuole uscire a tutte le ore e ci si trova di fronte al rischio della borsa o della vita o semplicemente al cumulo di rifiuti che ammorba l’aria o al cafone che ti blocca il passo carraio. Si vuole dormire quando e quanto ci pare e ci si trova accanto il luogo di svago — uno di centinaia, ormai — dove c’è gente che “tira” per abitudine le quattro di mattina. Ci si possono permettere auto sempre più veloci e si finisce per passare le ore in coda ai semafori.
La riflessione sulla modernità si snoda dunque chiedendosi se non sia questa la vera chiave — modernità come individualismo senza freni, come dilatazione dei diritti individuali fino “a farsi male”, che porta con se l’indurimento e una crescita abnorme delle strutture —, l’angolatura giusta per leggere la modernità nella sua essenza e nei suoi riflessi politici e sociali e per sottoporla — forse — a una critica efficace, indicando dei rimedi o almeno delle piste alternative al suo trionfo illimitato in questa versione che sta dissolvendo la convivenza civile?